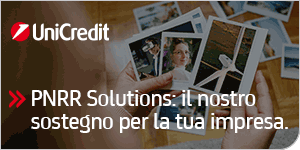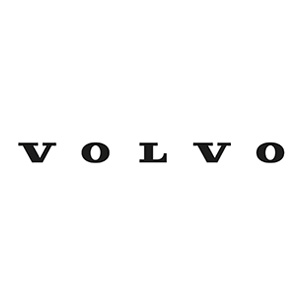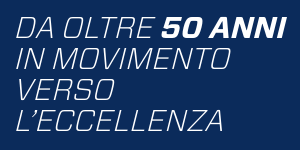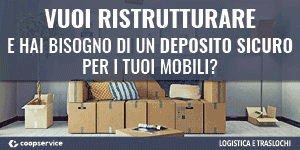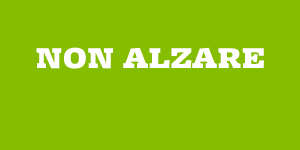Detto in altri termini, la legge ha come scopo quello di aiutare gli uomini a perfezionare la loro natura, la loro essenza (quello che li rende quello che sono).
Come ben scrive Michel Bastit, noto professore di filosofia antica e medioevale, la legittimità della legge sta, dunque, nella sua conformità all'ordine naturale. Il legislatore, allora, non è un sovrano, secondo la dottrina politologica moderna, bensì colui che, per primo, è chiamato ad obbedire alle leggi non scritte e, mediante la legge positiva, svolgere una funzione ordinatrice. La legge, dunque, non è né l'espressione della volontà dello Stato, né la conclusione di un dibattito pubblico (come, ad esempio, ritiene il cardinale Angelo Scola nel suo libro "Una nuova laicità", scritto nel 2007 durante gli anni del Patriarcato veneziano, ove riduce lo Stato, che non deve essere indifferente all'esito del confronto, a strumento servente della società civile la quale, in questo modo, diventa la regola dell'ordine giuridico).
La modernità ha completamente stravolto questa impostazione ed ad oggi non c'è forza politica in grado di porre un freno alla deriva nichilistica della legge.
Questa, infatti, individua il proprio fondamento nella sovranità, da intendersi come supremazia, come "plenitudo potestatis" nel senso bodiniano, ed il proprio fine nella funzione contingentemente assegnatale dalla sovranità medesima. In questo modo, la funzione coincide con il fine: neutralizzare il conflitto sociale, conciliare potere e libertà, garantire la proprietà privata etc.
A sua volta, la postmodernità, nella quale siamo oggi pienamente inseriti, ha radicalizzato la liberazione della legge dallo "ius", dalla "iustitia", favorendo la trasformazione di ogni pretesa in diritto (l'interruzione volontaria della gravidanza, la possibilità, tramite DAT (Dichiarazioni anticipate di trattamento), di rifiutare l'alimentazione mediante sondino naso/gastrico etc.).
Ora, le forze politiche tanto di centro-sinistra, quanto di centro-destra, che oggi chiedono il voto per le elezioni europee, hanno sempre perpetrato il "peccato originante" della modernità, mostrando di essere le due facce della stessa medaglia, ovvero concepire la legge come espressione del potere-forza a scapito della sua unica e vera concezione quale "partecipazione della giustizia".