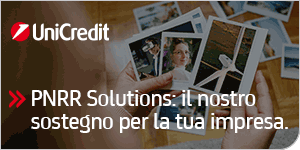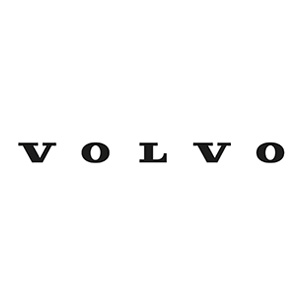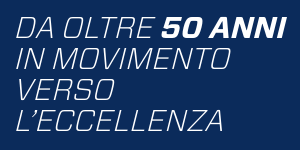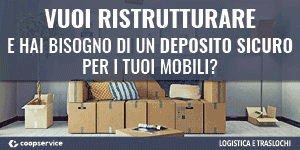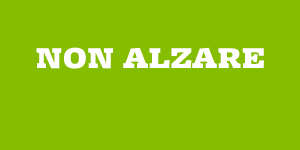Di Francesca Dallatana Parma, 23 giugno 2024 -
Balze di arancione, in discesa dalla scalinata-monumento che collega la via Nazionale alla via Verdi, verso la stazione dei treni. E’ il primo giorno dell’estate 2024. Fornovo di Taro è un saliscendi di scalini, di slarghi inaspettati, di borghi lastricati di acciottolato. E di colori nuovi. Tra il fiume inquieto o in secca e il monte che lo osserva. Un foulard dello stesso arancione del vestito trattiene uno chignon di riccioli sbarazzini in una acconciatura morbida. Scalinata, stazione dei treni: comincia così l’intervista.
Vicky Djoumessi vive a Fornovo di Taro dal 2021. Viene dal Camerun ed è in Italia dal 2014 per motivi di studio. E’ una studentessa dell’Università di Parma, facoltà di Farmacia. Una giovane donna, una ragazza, interessata e disponibile al dialogo con la comunità di accoglienza.
L’italiano è fluente e aperto come lo sguardo. Narrazione senza veli nonostante l’emozione del racconto della propria storia di vita italiana.
Fornovo di Taro rappresenta un nuovo inizio nel percorso di integrazione. Recentemente è cominciata la collaborazione con l’associazione Auser, con la quale segue un progetto di supporto alla mobilità dei bambini che frequentano la scuola. “Con l’Auser si è sviluppato un rapporto molto carino e vivace. I colleghi chiedono dei miei studi, di me e della mia vita qui. Mi sento parte del gruppo”, racconta la studentessa. “Ma la mia relazione con Fornovo era già iniziata, in un bar della via Nazionale, dove adesso c’è un ristorante. Andavo a studiare al bar, qualche volta. E la titolare mi aveva riservato un tavolo. Era il mio posto. Bellissimo parlare con lei. Era uno scambio personale e profondo. Lei mi diceva cose di se stessa e, a volte, condivideva anche le sue preoccupazioni. E anche io le parlavo di me, dei miei studi, dei miei progetti e della mia vita. Ci capivamo. La conoscenza della lingua è uno degli strumenti dell’integrazione. E’ il primo, ma non è l’unico.”
Vicky Djoumessi conosce già la lingua italiana al suo arrivo in Italia nel 2014. L’ha studiata a Yaoundé, in Camerun. Anche per questo motivo si aggiudica una borsa di studio ER.GO per l’Università. “La lingua è solo uno strumento. E’ fondamentale conoscere i codici di comunicazione e sociali del Paese di accoglienza. E non è immediata la capacità di entrare in sintonia con un gruppo di cultura diversa rispetto a quella di provenienza. Con la titolare del bar di via Nazionale è scattata una disponibilità reciproca. E’ così che si abbattono le barriere.”, osserva.
Uno scambio di attenzioni, risonanza empatica scaturita da una richiesta profonda di comunicazione. Un duetto sulla stessa base strumentale: voci soliste in alternanza e complementari, non voci in solitudine.
“Le relazioni si costruiscono nel corso del tempo. Bisogna incontrarsi. Al bar ho incontrato una persona. All’Auser ho incontrato diverse persone”, dice la neo-fornovese. “All’Università, invece, nel primo periodo ho vissuto qualche difficoltà. La mia facoltà organizza diversi laboratori, collegati alle discipline di studio. Nella fase di creazione dei gruppi di lavoro, composti da tre o quattro studenti, ci si sceglie spontaneamente. I gruppi si auto-definiscono. Qualche volta è capitato che un docente dovesse imporre la mia presenza, il mio nome, a un gruppo. Perché ero rimasta fuori dai gruppi, ero rimasta sola. E’ capitato anche che il docente non intervenisse nel proporre il mio nome. In questo caso ho dovuto fare il lavoro richiesto da sola. All’interno del gruppo si lavora e ci si confronta e si elegge un portavoce che poi riassume le conclusioni della riflessione corale a tutti gli allievi. Da soli si può fare molto poco, niente.”
Quali barriere, quali le cause di queste difficoltà? “Ero l’unica studentessa proveniente dall’Africa. L’unica con la pelle nera. Ma non credo fosse questo il motivo. Il motivo è collegato a una comunicazione culturale. Le modalità di aggregazione sociali non sono immediate. Non c’è stata spontaneità da parte degli altri studenti nel coinvolgermi nei loro gruppi. Non mi conoscevano. Ma non c’è stata neanche una richiesta da parte mia, un avvicinamento. Avrei potuto dire: posso venire con voi? Invece, loro non mi hanno chiamato e io non ho chiesto. A volte ci nascondiamo dietro a barriere di difesa. Non si vuole fare vedere la propria umana debolezza. E si rimane fermi in un atteggiamento di rigidità, di fierezza.”
E’ servita questa esperienza? “A me per capire e per riflettere. A tutte le persone provenienti dal Camerun e dall’Africa con le quali sono entrata in contatto è servita, perché ho raccontato. A tutte dico che dobbiamo impegnarci per superare queste difficoltà. Noi veniamo da un sistema educativo molto diverso rispetto a quello italiano. Conoscere il metodo di qui e i codici comunicativi e sociali del Paese di accoglienza facilita le cose. Questa è stata una debolezza nel mio percorso.”
Lo studio e il lavoro: una studentessa-lavoratrice oppure una lavoratrice-studentessa? “Una studentessa-lavoratrice. Sono venuta in Italia per studiare. Ho perso il supporto economico della borsa di studio ER.GO per pochi punti. Qualcuno mi ha detto: vai a parlare con i professori e cerca di spiegare la tua situazione. Non l’ho fatto. Io vengo da una famiglia con capacità economiche normali. Avevo bisogno della borsa di studio. Ho sempre lavorato durante l’estate, a partire dai primi anni dell’Università. Mesi di lavoro, turni di lavoro, un lavoro nelle fabbriche di trasformazione del pomodoro: presso la Columbus fino alla chiusura e presso la fabbrica Mutti. Poi un lavoro come addetta all’imballaggio e al confezionamento in un’azienda di un altro settore. Il lavoro è importante perché permette di essere autonomi ma rallenta lo studio. E in una facoltà scientifica, come Farmacia, è fondamentale dedicare tempo in modo regolare alla preparazione degli esami. A tutte le colleghe che hanno iniziato il percorso universitario e che hanno la borsa di studio ho suggerito di studiare e basta. Alcune di loro si sono laureate prima di me. Consigliare in modo generoso ha effetti sociali positivi”.
Al lavoro, l’integrazione è stata più facile? “Nelle industrie di trasformazione del pomodoro, ho lavorato a lungo alla cernita, in linea. Eravamo soprattutto operaie africane. Alcune, studentesse. Faceva molto caldo e non era facile resistere. Ma avevo imparato a chiedere. Ho chiesto se fosse possibile fare un’esperienza di lavoro nel laboratorio. Mi hanno detto che non era possibile. Dopo qualche tempo ho cominciato a sostituire una operaia camerunense come me alle piscine. Quel posto di lavoro è un posto di potere. Si regolano i flussi dei pomodori verso le linee. Ho avuto la possibilità di collaborare con diverse altre figure della fabbrica. Poi, la collega se ne è andata dall’Italia e l’anno successivo l’ho sostituita per tutto il periodo.”
Ci sono state possibilità di conoscenza e di socializzazione con gli altri operai? “Ricordo una relazione molto bella con una operaia moldava, molto grande di età. Ero stupita che una persona così grande lavorasse ancora. Per questo motivo, le chiedevo se aveva bisogno di aiuto e se potevo fare qualche cosa per lei. Lei era una persona molto gentile. Nessuna barriera per il colore della pelle.”
L’Università, le fabbriche, le difficoltà di integrazione e la tenacia nella costruzione della rete sociale. Ci sono altre esperienze significative nel percorso italiano? “Una collaborazione con una famiglia, medico lei e ingegnere lui. Genitori di tre bambini. Sono stata la loro baby sitter. E loro sono diventati la mia famiglia italiana. Sono africani, come me. Hanno studiato in Italia, come me. Hanno fatto fatica a farsi accettare. Lei, la dottoressa, mi raccontava delle difficoltà con i pazienti. La guardavano con preoccupazione, nonostante lei venisse da una formazione universitaria italiana. La stessa situazione l’ha vissuta lui, l’ingegnere. In Italia, nessuna possibilità di promozione, di carriera. Si sono trasferiti in Germania, a Solingen. Vado spesso da loro. Sono la mia famiglia europea. In Germania, il loro percorso di lavoro è stato facile. Lavorano, si sono integrati. Sono contenti del lavoro e di come si lavora.”
La fuga dei cervelli rappresenta un grande problema per l’Italia. “Molte delle persone che conosco hanno studiato qui. I miei amici se ne sono andati a Solingen. Quelli che sono rimasti sono medici e infermieri e professionisti e mi dicono delle loro difficoltà a farsi accettare. I colleghi e i pazienti spesso mettono in discussione le loro competenze, la loro professionalità. Dobbiamo lavorare molto per cancellare queste barriere. Noi studiamo qui. Vorremmo rimanere qui. Questo Paese ha investito su di noi.”
Quale futuro per la studentessa Vicky Djoumessi?
“Dai colleghi dell’Auser arriva il forte suggerimento di terminare gli studi. Sono motivata a seguirlo. Dovrò fare un tirocinio. Al termine degli studi mi piacerebbe utilizzare le competenze acquisite nel laboratorio di un’azienda, in una farmacia oppure impegnarmi in una attività commerciale. Mi piace molto la relazione. Mi piacerebbe partire dalle mie attitudini e creare un brand per la cosmesi. E vendere. E' un'idea.”
Il rapporto con il Camerun? “In Camerun la vita è calda. In Italia le persone lavorano tanto e non sono contente. In Camerun si vive con poco. La socialità è molto vivace. Sono andata un anno fa. Ero bella anche senza skincare! Perché la vita scorre in modo diverso. Mi manca la mia famiglia, mi manca il mio Paese. La mia famiglia europea, invece, la raggiungo in Germania. Noi tutti siamo cittadini del mondo.”
Un suggerimento per avvicinare gli italiani al Camerun? Un libro?
“L’autore è Kevin Dango, camerunense. Un libro per prepararsi ad essere un buon imprenditore. E’ l’ultimo che ho letto. Per conoscere il mio Paese di origine, invece, un altro autore: Germain Metanmo. E’ il nonno della mia famiglia tedesca. Il libro parla della mia cultura. Sono del Camerun occidentale. L’autore tiene molto alla conservazione delle culture e alla loro diffusione. Germain Metanmo ha un progetto molto ambizioso, ma possibile: aprire una biblioteca in Camerun dedicata alla nostra storia e permettere alle persone di frequentarla e di leggere gratuitamente.” Cultura: ponte dell’integrazione. Una scalinata impegnativa da scendere e salire, nei due sensi. Incrociando e cambiando il senso di marcia. Per confondere le balze di colore con gli scalini. Per disegnare il grande affresco sociale multicolore.

_________________________________________________________________
(Link rubrica: La Biblioteca del lavoro e lavoro migrante ” https://gazzettadellemilia.it/component/search/?searchword=francesca%20dallatana&searchphrase=all&Itemid=374
https://www.gazzettadellemilia.it/component/search/?searchword=lavoro%20migrante&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=30)